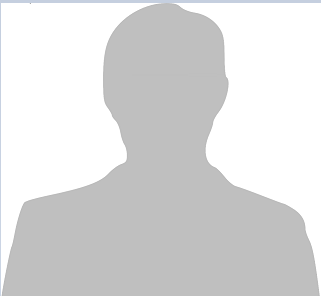...
Show More
senza titolo
Mi pare che vi siano innumerevoli maniere di prendere questo romanzo, di affrontarlo al principio e di valutarlo dopo la lettura.
Lo si può considerare un prototipo di Infinite Jest, tanti e tali sono le analogie, i personaggi de “La Scopa” che ne prefigurano altri di IJ, le invenzioni di stile e di contenuto, gli ambienti, le famiglie, la scelta dei nomi, eccetera, che sarebbe pressoché impossibile compilarne un elenco preciso. Si fa prima a fare il discorso inverso osservando che l’elemento che più differenzia le due opere è l’assenza in “La scopa” dell’enorme apparato di note, subnote, subsubnote presente in IJ. Che non è solo una ricercatezza di stile ma induce ad una modalità di lettura completamente diversa.
Oppure si può procedere a partire dal senso di ammirato stupore per l’esordio di un autore ventiquattrenne già in grado di mettere in piedi un’architettura narrativa di tale complessità, precisione, talento innovativo, torrente di idee, suggestioni, situazioni, invenzioni da togliere il fiato e da sembrare, più che un’opera prima, la summa di un autore giunto all’apice della propria capacità creativa: un testo e uno stile quasi imprescindibili nella narrativa alla fine e, mi sbilancio, a coronamento di un secolo che pure di geni letterari ne ha profusi in grande quantità.
Un’altra modalità di approccio (alludo sempre sia alla disposizione mentale del lettore a pagina 1, sia a quella retrospettiva di chi è arrivato alla “fine”, posto che quest’ultima parola mai come qui appaia deliberatamente destituita di significato…) è l’impegno ad un’analisi razionale delle principali fondamenta dell’opera, la ricerca di uno o più bandoli della rete intricata che Wallace lascia lungo il percorso. E’ la strada scelta con coraggio da Bartezzaghi, nella sua prefazione al romanzo, che personalmente ho trovato pregevole meravigliandomi assai per le numerose critiche che ha suscitato: molte fra le osservazioni del prefatore aggiungono valore e interessanti itinerari all’approfondimento della conoscenza di un autore e in particolare di un’opera talmente sfaccettata.
L’ultima scelta (ma in realtà ce ne sarebbero altre) è quella che sempre ci resta nei confronti di espressioni artistiche che sembrano trascendere le nostre capacità di completa assimilazione: l’abbandonarsi alla corrente di un magma che contiene frammenti inafferrabili e non collocabili, ma anche perle di grande valore come il racconto “Amore”, incastonato fra i demenziali prodotti della fantasia distorta di Rick Vigorous oppure il personaggio di Lavache nel (troppo) breve intermezzo di metà romanzo che lo vede in primo piano.
Il povero lettore qualunque può oscillare fra l’uno o l’altro di questi sentieri, purché conservi la consapevolezza (pena cocenti delusioni) che non ha senso attendersi uno sbocco rassicurante e definitivo, così come non ha senso domandarsi come sia possibile avere concluso “La scopa del sistema” senza averne mai raggiunto, spiegato, udito direttamente la nonnina protagonista; non avere compreso nell’ultima riga se R.V. si consideri un uomo di parola o un uomo di merda; non avere colto cosa accade a Lenore nel crescendo del penultimo capitolo dove il suo silenzio sempre più assoluto fa da inquietante contrappunto al baccano di tutti o quasi i personaggi ritrovati nella stessa stanza come in una comica finale o in una commedia degli errori…
D’altra parte io stesso non saprei proprio come esprimere in altro modo la
Mi pare che vi siano innumerevoli maniere di prendere questo romanzo, di affrontarlo al principio e di valutarlo dopo la lettura.
Lo si può considerare un prototipo di Infinite Jest, tanti e tali sono le analogie, i personaggi de “La Scopa” che ne prefigurano altri di IJ, le invenzioni di stile e di contenuto, gli ambienti, le famiglie, la scelta dei nomi, eccetera, che sarebbe pressoché impossibile compilarne un elenco preciso. Si fa prima a fare il discorso inverso osservando che l’elemento che più differenzia le due opere è l’assenza in “La scopa” dell’enorme apparato di note, subnote, subsubnote presente in IJ. Che non è solo una ricercatezza di stile ma induce ad una modalità di lettura completamente diversa.
Oppure si può procedere a partire dal senso di ammirato stupore per l’esordio di un autore ventiquattrenne già in grado di mettere in piedi un’architettura narrativa di tale complessità, precisione, talento innovativo, torrente di idee, suggestioni, situazioni, invenzioni da togliere il fiato e da sembrare, più che un’opera prima, la summa di un autore giunto all’apice della propria capacità creativa: un testo e uno stile quasi imprescindibili nella narrativa alla fine e, mi sbilancio, a coronamento di un secolo che pure di geni letterari ne ha profusi in grande quantità.
Un’altra modalità di approccio (alludo sempre sia alla disposizione mentale del lettore a pagina 1, sia a quella retrospettiva di chi è arrivato alla “fine”, posto che quest’ultima parola mai come qui appaia deliberatamente destituita di significato…) è l’impegno ad un’analisi razionale delle principali fondamenta dell’opera, la ricerca di uno o più bandoli della rete intricata che Wallace lascia lungo il percorso. E’ la strada scelta con coraggio da Bartezzaghi, nella sua prefazione al romanzo, che personalmente ho trovato pregevole meravigliandomi assai per le numerose critiche che ha suscitato: molte fra le osservazioni del prefatore aggiungono valore e interessanti itinerari all’approfondimento della conoscenza di un autore e in particolare di un’opera talmente sfaccettata.
L’ultima scelta (ma in realtà ce ne sarebbero altre) è quella che sempre ci resta nei confronti di espressioni artistiche che sembrano trascendere le nostre capacità di completa assimilazione: l’abbandonarsi alla corrente di un magma che contiene frammenti inafferrabili e non collocabili, ma anche perle di grande valore come il racconto “Amore”, incastonato fra i demenziali prodotti della fantasia distorta di Rick Vigorous oppure il personaggio di Lavache nel (troppo) breve intermezzo di metà romanzo che lo vede in primo piano.
Il povero lettore qualunque può oscillare fra l’uno o l’altro di questi sentieri, purché conservi la consapevolezza (pena cocenti delusioni) che non ha senso attendersi uno sbocco rassicurante e definitivo, così come non ha senso domandarsi come sia possibile avere concluso “La scopa del sistema” senza averne mai raggiunto, spiegato, udito direttamente la nonnina protagonista; non avere compreso nell’ultima riga se R.V. si consideri un uomo di parola o un uomo di merda; non avere colto cosa accade a Lenore nel crescendo del penultimo capitolo dove il suo silenzio sempre più assoluto fa da inquietante contrappunto al baccano di tutti o quasi i personaggi ritrovati nella stessa stanza come in una comica finale o in una commedia degli errori…
D’altra parte io stesso non saprei proprio come esprimere in altro modo la