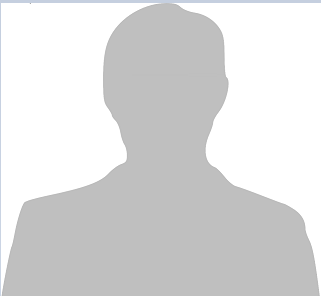...
Show More
La motivazione per la quale Orhan Pamuk ha vinto nel 2006 il premio nobel per la letteratura dice "che nel ricercare l'anima malinconica della sua città natale, ha scoperto nuovi simboli per rappresentare scontri e legami fra diverse culture"
Il mio nome è rosso narra proprio di uno scontro tra due diverse culture, due diverse visioni del mondo in cui la differenza è il posto che l’uomo occupa nel creato. Ma non solo questo, Il mio nome è rosso è anche la storia di un assassinio e della ricerca del colpevole; è la storia di un uomo e di una donna che devono affrontare i fantasmi del passato per potersi rappropriare del proprio presente.
La vicenda si svolge a Istanbul nel 1591; l’oggetto della contesa è un misterioso libro che il Sultano, in gran segreto, sta facendo illustrare utilizzando le tecniche pittoriche europee. Attorno questo misterioso libro si muovono tutti i personaggi: Raffinato Effendi (doratore di talento e vittima di un efferato omicidio che trova il movente proprio nel libro segreto), Zio Effendi (che, per conto del Sultano, supervisiona la realizzazione del libro), maestro Osman (capo miniaturista del laboratorio reale che disprezza il metodo europeo), i maestri miniaturisti (Oliva, Cicogna e Farfalla, tra i quali si nasconde l’assassino, che in gran segreto aiutano Zio Effendi nell’illustrazione del libro), Șeküre (la bella figlia di Zio effendi, legata dalla legge a un marito probabilmente morto in guerra da diversi anni e alla di lui famiglia), Nero (nipote di Zio Effendi e da sempre innamorato di Șeküre), l’ebrea Esther (venditrice di corredi ma soprattutto sensale di matrimoni), gli stessi personaggi del libro segreto che non perdono occasione per dire la loro su tutta la faccenda del metodo migliore per raffigurarli.
Si tratta di una materia affascinante che, però, rende la vicenda “densa”: ogni parola, ogni frase deve essere pienamente compresa per poter procedere nel percorso tracciato dall’autore. Il mio nome è rosso è un libro che va assaporato lentamente come un vino pregiato per poterne cogliere le sfumature, i rimandi continui alla cultura e alla storia turca, alla concezione dell’uomo nella religione islamica. È una vicenda che richiede approfondimenti sull’arte della miniatura per comprendere e, soprattutto, vedere quei disegni che Pamuk descrive in ogni pagina. Internet è un supporto necessario alla comprensione di questo libro e, per fortuna, dentro al rete possiamo trovare quasi tutto: le immagini delle miniature del periodo ottomano e quelle delle epoche successive (soprattutto quelle più vicine a noi) per comprendere come questa forma d’arte si sia modificata in seguito alle influenze occidentali; gli articoli sulla storia della miniatura che illustrano le diverse scuole con la loro tecnica e la loro estetica; i compendi di letteratura che ci fanno conoscere l’epoca d’oro degli autori bizantini e ottomani.
Date queste premesse, scrivere su questo libro è veramente difficile perché, leggendolo, mi sono resa conto di non conoscere quasi nulla della storia turca e, soprattutto, della religione islamica, nonostante il mio continuo ricorso a google e wikipedia (non voglio affermare che sia questo il modo migliore per acquisire nuove conoscenze, ma in mancanza di altri supporti è già qualcosa). Per fortuna Pamuk conosce e utilizza molto bene anche i fondamenti filosofici della cultura occidentale e quindi alcuni aspetti penso di averli compresi, o quanto meno di avergli dato un senso e una mia chiave di lettura. So bene che non riuscirò a scrivere tutto quello che ho trovato dentro questo libro, ma questo non è male sia per evitare recensioni fiume (anche se questa lo è) sia per suscitare qualche curiosità e spingervi a leggere il libro, che, per me, è un vero capolavoro.
La questione intorno alla quale dibattono tutti i miniaturisti del romanzo è, fuori da ogni metafora, il ruolo dell’uomo nel mondo e il suo rapporto con il creato. Gli europei pensano che l’uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio e salvato da un Dio che si è fatto uomo, debba stare al centro dell’universo e possa esercitare il suo predominio sul mondo che Dio gli ha donato, come scritto nella Genesi:
La filosofia europea (l’umanesimo e tutto quello che segue) mette l’uomo al centro del mondo e i pittori interpretano alla lettera questa superiorità di posizione rispetto all’intero creato mettendo le persone ritratte al centro della tela. Non solo, i grandi maestri europei ricreano sulla tela la realtà così come la vedono, utilizzando la prospettiva e il colore nelle sue diverse gradazioni per riprodurre le distorsioni percettive che la nostra mente utilizza per avere informazioni sul mondo che ci circonda. L’uomo, come Dio, diventa creatore e sulla tela non si limita a riportare una figura umana ma riproduce uno specifico soggetto (in genere il committente) che in questo modo diventa immortale, riuscendo a superare i limiti di tempo e spazio per farsi ammirare dalle generazioni successive.
I miniaturisti islamici invece sanno che al centro dell’universo c’è la volontà di Allah.
La rappresentazione pittorica serve ad illustrare il testo, non può avere autonomia perché l’uomo non può creare nulla, neanche come semplice riproduzione. Le immagini non devono diventare idoli come accadrebbe se avessero una loro intrinseca dignità e fossero appese alla parete per essere ammirate. Compito supremo del miniaturista è riprodurre il mondo come lo vede Allah, che con un solo sguarda abbraccia tutto il creato: oriente e occidente, passato e presente. Tutta la vita del miniaturista è volta verso la conquista della visione di Allah, trascendendo l’ingannevole visione che del mondo gli forniscono gli occhi e la mente: per tale ragione, il massimo dono che Allah fa ai miniaturisti è la cecità, il buio totale grazie al quale è possibile accedere a quelle categorie universali che sono la vera essenza del reale.
Per illustrare la sua tesi, Pamuk ci descrive migliaia di miniature che, nella maggior parte dei casi, hanno sempre lo stesso soggetto, ma ciascuna delle quali serve ad aggiungere un tassello alle diverse tesi riportate nel libro. Sicuramente questo rende la lettura del libro più lenta, ma (per me) assolutamente interessante e senza un attimo di noia perché in ogni descrizione ho cercato di coglierne il senso.
È chiaro (o almeno lo è per me) che da queste due antitetiche visioni dell’uomo, discendono una serie di conseguenze che sono ancora oggi sotto i nostri occhi. Estremizzando e semplificando, la posizione occidentale ha, gradatamente, portato l’uomo a separare la religione dalla politica e dalla regolamentazione sociale (almeno ufficialmente c’è una separazione tra Stato e Chiesa). La posizione islamica, almeno nelle sue forme fondamentaliste, subordina sempre l’operato dell’uomo alla volontà di Dio (sia ben inteso, la volontà di Dio come gli uomini la recepiscono e la interpretano).
Quindi meglio l’Occidente dell’Oriente islamico? Pamuk, almeno mi sembra, suggerisce che esiste, deve esistere, una terza via che è la contaminazione e la possibilità di accogliere i fermenti che giungono da altre culture.
È impossibile fermare i la contaminazione, ma esplicitandola è possibile governarla. Il rischio, viceversa, è quello di essere sopraffatti e di non riuscire a valorizzare il proprio patrimonio culturale.
Trovate questa conclusione banale? Se è così è perché io l’ho resa tale: solo leggendo il libro si può cogliere la bravura di Pamuk che riesce a mescolare tutti gli aspetti e a calare queste complesse discussioni filosofiche nella quotidianità dei miniaturisti del Sultano, utilizzando uno stile non privo di ironia, per cui i personaggi del libro sono consapevoli di essere parte di una storia e non esitano a rivolgersi al lettore per conquistarne la benevolenza. I diversi protagonisti sono ben caratterizzati e non sono delle semplici voci di una posizione filosofica. Ne è la prova che mentre leggevo cercavo continuamente degli indizi per capire chi fosse l’assassino, mi arrabbiavo (al punto che l’avrei picchiata) con Șeküre per l’incapacità di assumersi la responsabilità delle sue azioni, provavo sincera ammirazione per la capacità di mediazione di Esther e la sincerità dei suoi sentimenti.
Se siete arrivati sino a qui, siete persone curiose e pazienti, avete tutti i numeri per sfidare Orhan Pamuk e conoscere il Rosso.
Il mio nome è rosso narra proprio di uno scontro tra due diverse culture, due diverse visioni del mondo in cui la differenza è il posto che l’uomo occupa nel creato. Ma non solo questo, Il mio nome è rosso è anche la storia di un assassinio e della ricerca del colpevole; è la storia di un uomo e di una donna che devono affrontare i fantasmi del passato per potersi rappropriare del proprio presente.
La vicenda si svolge a Istanbul nel 1591; l’oggetto della contesa è un misterioso libro che il Sultano, in gran segreto, sta facendo illustrare utilizzando le tecniche pittoriche europee. Attorno questo misterioso libro si muovono tutti i personaggi: Raffinato Effendi (doratore di talento e vittima di un efferato omicidio che trova il movente proprio nel libro segreto), Zio Effendi (che, per conto del Sultano, supervisiona la realizzazione del libro), maestro Osman (capo miniaturista del laboratorio reale che disprezza il metodo europeo), i maestri miniaturisti (Oliva, Cicogna e Farfalla, tra i quali si nasconde l’assassino, che in gran segreto aiutano Zio Effendi nell’illustrazione del libro), Șeküre (la bella figlia di Zio effendi, legata dalla legge a un marito probabilmente morto in guerra da diversi anni e alla di lui famiglia), Nero (nipote di Zio Effendi e da sempre innamorato di Șeküre), l’ebrea Esther (venditrice di corredi ma soprattutto sensale di matrimoni), gli stessi personaggi del libro segreto che non perdono occasione per dire la loro su tutta la faccenda del metodo migliore per raffigurarli.
Si tratta di una materia affascinante che, però, rende la vicenda “densa”: ogni parola, ogni frase deve essere pienamente compresa per poter procedere nel percorso tracciato dall’autore. Il mio nome è rosso è un libro che va assaporato lentamente come un vino pregiato per poterne cogliere le sfumature, i rimandi continui alla cultura e alla storia turca, alla concezione dell’uomo nella religione islamica. È una vicenda che richiede approfondimenti sull’arte della miniatura per comprendere e, soprattutto, vedere quei disegni che Pamuk descrive in ogni pagina. Internet è un supporto necessario alla comprensione di questo libro e, per fortuna, dentro al rete possiamo trovare quasi tutto: le immagini delle miniature del periodo ottomano e quelle delle epoche successive (soprattutto quelle più vicine a noi) per comprendere come questa forma d’arte si sia modificata in seguito alle influenze occidentali; gli articoli sulla storia della miniatura che illustrano le diverse scuole con la loro tecnica e la loro estetica; i compendi di letteratura che ci fanno conoscere l’epoca d’oro degli autori bizantini e ottomani.
Date queste premesse, scrivere su questo libro è veramente difficile perché, leggendolo, mi sono resa conto di non conoscere quasi nulla della storia turca e, soprattutto, della religione islamica, nonostante il mio continuo ricorso a google e wikipedia (non voglio affermare che sia questo il modo migliore per acquisire nuove conoscenze, ma in mancanza di altri supporti è già qualcosa). Per fortuna Pamuk conosce e utilizza molto bene anche i fondamenti filosofici della cultura occidentale e quindi alcuni aspetti penso di averli compresi, o quanto meno di avergli dato un senso e una mia chiave di lettura. So bene che non riuscirò a scrivere tutto quello che ho trovato dentro questo libro, ma questo non è male sia per evitare recensioni fiume (anche se questa lo è) sia per suscitare qualche curiosità e spingervi a leggere il libro, che, per me, è un vero capolavoro.
La questione intorno alla quale dibattono tutti i miniaturisti del romanzo è, fuori da ogni metafora, il ruolo dell’uomo nel mondo e il suo rapporto con il creato. Gli europei pensano che l’uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio e salvato da un Dio che si è fatto uomo, debba stare al centro dell’universo e possa esercitare il suo predominio sul mondo che Dio gli ha donato, come scritto nella Genesi:
[27] Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò;
maschio e femmina li creò.
[28] Dio li benedisse e disse loro:
"Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra;
soggiogatela e dominate
sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente,
che striscia sulla terra".
La filosofia europea (l’umanesimo e tutto quello che segue) mette l’uomo al centro del mondo e i pittori interpretano alla lettera questa superiorità di posizione rispetto all’intero creato mettendo le persone ritratte al centro della tela. Non solo, i grandi maestri europei ricreano sulla tela la realtà così come la vedono, utilizzando la prospettiva e il colore nelle sue diverse gradazioni per riprodurre le distorsioni percettive che la nostra mente utilizza per avere informazioni sul mondo che ci circonda. L’uomo, come Dio, diventa creatore e sulla tela non si limita a riportare una figura umana ma riproduce uno specifico soggetto (in genere il committente) che in questo modo diventa immortale, riuscendo a superare i limiti di tempo e spazio per farsi ammirare dalle generazioni successive.
I miniaturisti islamici invece sanno che al centro dell’universo c’è la volontà di Allah.
n Devo dirvi che tutto quello che ci accade può venire narrato in un libro, ma disegnarlo non si può, e non lo possono fare neanche i miniaturisti più esperti. Proprio come il Corano – che non si intenda male, Allah non voglia! – la forza sconvolgente di un libro dipende anche dal fatto che non può mai essere narrato attraverso i disegni. Temo che non abbiate capito. n
La rappresentazione pittorica serve ad illustrare il testo, non può avere autonomia perché l’uomo non può creare nulla, neanche come semplice riproduzione. Le immagini non devono diventare idoli come accadrebbe se avessero una loro intrinseca dignità e fossero appese alla parete per essere ammirate. Compito supremo del miniaturista è riprodurre il mondo come lo vede Allah, che con un solo sguarda abbraccia tutto il creato: oriente e occidente, passato e presente. Tutta la vita del miniaturista è volta verso la conquista della visione di Allah, trascendendo l’ingannevole visione che del mondo gli forniscono gli occhi e la mente: per tale ragione, il massimo dono che Allah fa ai miniaturisti è la cecità, il buio totale grazie al quale è possibile accedere a quelle categorie universali che sono la vera essenza del reale.
“Si, sono cieco – gli disse – Ma ho in mente tutte le meraviglie del libro che ho dipinto in questi ultimi undici anni, ricordo ogni tocco di penna e di pennello e la mia mano sa disegnare a memoria senza che io debba vedere. Mio Khan, io posso dipingere per te il più bel libro mai visto fino a oggi. Perché i miei occhi ormai non possono più soffermarsi sulle brutture di questo mondo ed esserne distratti, posso disegnare a memoria e nel modo più puro le meraviglie di Allah”
Per illustrare la sua tesi, Pamuk ci descrive migliaia di miniature che, nella maggior parte dei casi, hanno sempre lo stesso soggetto, ma ciascuna delle quali serve ad aggiungere un tassello alle diverse tesi riportate nel libro. Sicuramente questo rende la lettura del libro più lenta, ma (per me) assolutamente interessante e senza un attimo di noia perché in ogni descrizione ho cercato di coglierne il senso.
È chiaro (o almeno lo è per me) che da queste due antitetiche visioni dell’uomo, discendono una serie di conseguenze che sono ancora oggi sotto i nostri occhi. Estremizzando e semplificando, la posizione occidentale ha, gradatamente, portato l’uomo a separare la religione dalla politica e dalla regolamentazione sociale (almeno ufficialmente c’è una separazione tra Stato e Chiesa). La posizione islamica, almeno nelle sue forme fondamentaliste, subordina sempre l’operato dell’uomo alla volontà di Dio (sia ben inteso, la volontà di Dio come gli uomini la recepiscono e la interpretano).
Quindi meglio l’Occidente dell’Oriente islamico? Pamuk, almeno mi sembra, suggerisce che esiste, deve esistere, una terza via che è la contaminazione e la possibilità di accogliere i fermenti che giungono da altre culture.
n Ad Allah appartengono l’Oriente e l’Occidente. Allah ci protegga dai desideri di colui che è puro e non si è mescolato.n
È impossibile fermare i la contaminazione, ma esplicitandola è possibile governarla. Il rischio, viceversa, è quello di essere sopraffatti e di non riuscire a valorizzare il proprio patrimonio culturale.
Trovate questa conclusione banale? Se è così è perché io l’ho resa tale: solo leggendo il libro si può cogliere la bravura di Pamuk che riesce a mescolare tutti gli aspetti e a calare queste complesse discussioni filosofiche nella quotidianità dei miniaturisti del Sultano, utilizzando uno stile non privo di ironia, per cui i personaggi del libro sono consapevoli di essere parte di una storia e non esitano a rivolgersi al lettore per conquistarne la benevolenza. I diversi protagonisti sono ben caratterizzati e non sono delle semplici voci di una posizione filosofica. Ne è la prova che mentre leggevo cercavo continuamente degli indizi per capire chi fosse l’assassino, mi arrabbiavo (al punto che l’avrei picchiata) con Șeküre per l’incapacità di assumersi la responsabilità delle sue azioni, provavo sincera ammirazione per la capacità di mediazione di Esther e la sincerità dei suoi sentimenti.
Se siete arrivati sino a qui, siete persone curiose e pazienti, avete tutti i numeri per sfidare Orhan Pamuk e conoscere il Rosso.